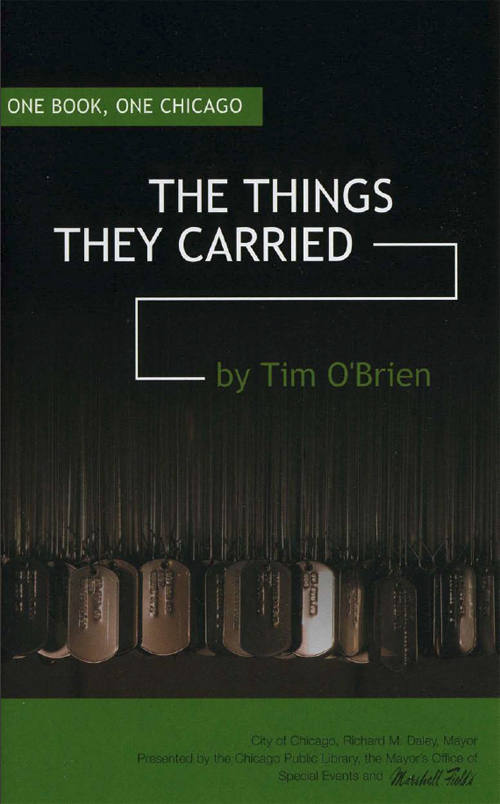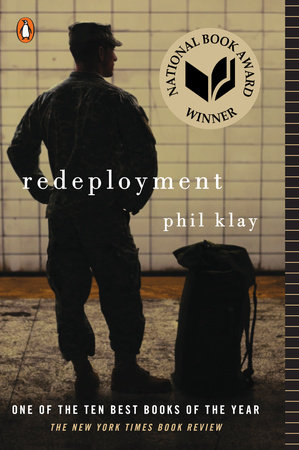But the thing about remembering is that you don’t forget.
Saltando di guerra in guerra (Allegriaaa amici!), da Redeployment che parla del conflitto in Iraq sono arrivata al Vietnam, poichè ho trovato ottimi suggerimenti per questo The things they carried, un libro del 1990, in Italia tradotto con Quanto pesano i fantasmi (credo sia fuori catalogo). In America è considerato un testo antologico in molte scuole, è stato finalista al Pulitzer, e nel 2014 in classifica Amazon per i Cento libri da leggere una volta nella vita. E’ effettivamente scritto davvero bene, è molto crudo ma con grandi momenti di lirismo, e lo definirei superiore a Redeployment, come testo bellico: è molto più intenso, la scrittura è migliore, più lirica e profonda. Infine, in questo libro c’è più empatia, e credo sia impossibile chiuderlo senza rimanere immersi per qualche tempo in uno stato di intensa commozione.
The things they carried è un romanzo composto da una serie di racconti, in cui i protagonisti -ricorrenti nelle varie storie- sono i soldati di un plotone che avanza nella giungla in Vietnam. L’autore, Tim O’Brien, in Vietnam ci finì davvero, militare di leva, quattordici mesi in fanteria tra il 1969 e il 1970; e quella guerra è diventata la sua fonte di ispirazione primaria, l’unica cosa di cui scrive (in genere molto bene: Inseguendo Cacciato, un altro suo famoso romanzo, fu premiato col National Book Award nel 1978). In questo libro O’Brien è presente, sia come narratore che protagonista: usa un genere di narrazione che ho scoperto si chiama “di verosimiglianza” in cui realtà e fiction si mescolano senza che sia possibile capire dove finisca l’una e inizi l’altra, cosa che personalmente non trovo sia così importante. Lo stesso autore chiarisce a che a volte la finzione spiega meglio la realtà di un libro di memorie.
Il primo racconto, quello che apre il libro e gli dà il titolo, è fenomenale, e credo che la traduzione italiana non sia in questo senso felicissima: Le cose che portavano, letteralmente, è un lungo elenco di tutto il carico fisico e spirituale, materiale e metaforico che ogni soldato di quel plotone, e ogni soldato di ogni conflitto, porta sulle sue spalle. Armi, munizioni e rifornimenti per cominciare, e poi talismani portafortuna e lettere da casa, droghe o vitamine, barrette di cioccolato o un paio di calzini puliti in più, fotografie della propria ragazza e una Bibbia. Portano se stessi, e spesso i compagni feriti o morti, fino al punto di atterraggio dell’elicottero. Portano infezioni virali e mazzi di carte, scacchiere giocattolo e cerotti, medaglie, pidocchi, e dissenteria. Portano, soprattutto, i sogni e gli incubi, la memoria dei caduti e le loro ultime risate nel sole di una risaia, il ricordo e la nostalgia di casa, la paura di non tornare e la consapevolezza che non sarebbero mai tornati veramente, “portavano tutto quello che riuscivano a sopportare, e anche qualcosa in più, incluso un silenzioso senso di meraviglia per il potere terribile di tutto quello che portavano”.
Prima di comprare questo libro mi sono chiesta se avesse ancora un senso, nel 2016, leggere un romanzo su una guerra combattuta da Paesi estranei in estranei continenti in anni in cui molti di noi non erano ancora nemmeno nati, o gattonavano appena. Poi ho letto un estratto nella prefazione, una frase che mi è entrata fissa in testa e non si è più schiodata: l’età media dei ragazzi di quel plotone era 19 anni. E tantissimi, troppi, lo sappiamo, non arrivarono mai a compierne di più. Così ho pensato che sì, queste storie non devono andare perse nella memoria. Un giorno lo saranno, inevitabilmente. Ma per adesso non ancora. Questi racconti viscerali e tormentati di Tim O’Brien devono continuare a parlarci di quei ragazzi che in un’età in cui noi, i nostri figli, al massimo ci si dibatte a scegliere la facoltà universitaria o il pagamento a rate della prima macchina, furono buttati in una giungla a contemplare senza parole i corpi di uomini che avevano ucciso brutalmente, ad assistere alla morte dei propri amici affogati in campi di fango e merda mentre intorno il mondo esplodeva in fuoco e granate, a desiderare per mesi un ritorno a casa che si rivelava poi senza senso, circondati da gente che non sapeva cosa dir loro, in una società che non aveva un posto per loro, nè tempo per le loro storie.
The Things They Carried è diventato, come dicevo, un testo che si legge in tutte le scuole americane, e moltissimi studenti lo scelgono come argomento dei propri saggi di presentazione per i college prescelti, con sorpresa dello stesso autore che ha sempre pensato il tema interessasse al massimo qualche adulto della sua età, che quegli anni li aveva vissuti. E’ un libro duro, crudo, a volte ripetitivo, non tutte le storie funzionano alla perfezione. Ma credo che piaccia molto ai ragazzi perchè al di là della propria natura di racconto in cui la verità muta e si altera nel tempo, è un libro essenzialmente vero. La guerra che viene descritta è orribile e crudele, sbagliata e insensata. Eppure ci sono momenti di bellezza e persino nostalgia, l’inevitabile Vietnam Blues di cui parlano molti veterani per quei momenti di terrore e amicizia in cui ti sei sentito davvero vivo. Quello che accade in combattimento può essere grottesco, assurdo, insensato, trascendente del momento, a volte tutte queste cose insieme. C’è il peso fisico della vita in trincea, stivali, fango, sudore, zanzare, la noia assurda della maggior parte dei momenti della giornata di marcia, e il passaggio in un nano secondo dal tedio al terrore puro nel momento in cui arriva un attacco, il suono di un sparo e la paura quando capisci di esser stato ferito, i tuoi occhi che si fissano su un sassolino o un po’ di erba pensando che sarà l’ultima cosa che vedrai su questa terra. C’è il tormento di guardarsi indietro, vent’anni e poi quarant’anni dopo che si è tornati, sempre cercando un senso per quello che si è fatto in Vietnam, e si osserva con sgomento il baratro che si è aperto tra il proprio io di quel momento in guerra e quello che vive ora in America con la propria famiglia e i nipoti.
C’è la fascinazione per la natura circostante, il forse inevitabile ma sincero cameratismo con il proprio plotone, l’ambiguità morale e lo humor nero che inevitabilmente caratterizzano le storie di ventenni americani in quella guerra.
Soprattutto, ci sono quel dolore e quella rabbia inestinguibili che sono parte del bagaglio invisibile delle Cose che portavano, e che costituiscono nel profondo di chi c’è stato, ancora dopo quarant’anni, il senso di tutto.
Lorenza Inquisition
“Often in a true war story there is not even a point, or else the point doesn’t hit you until 20 years later, in your sleep, and you wake up and shake your wife and start telling the story to her, except when you get to the end you’ve forgotten the point again.”