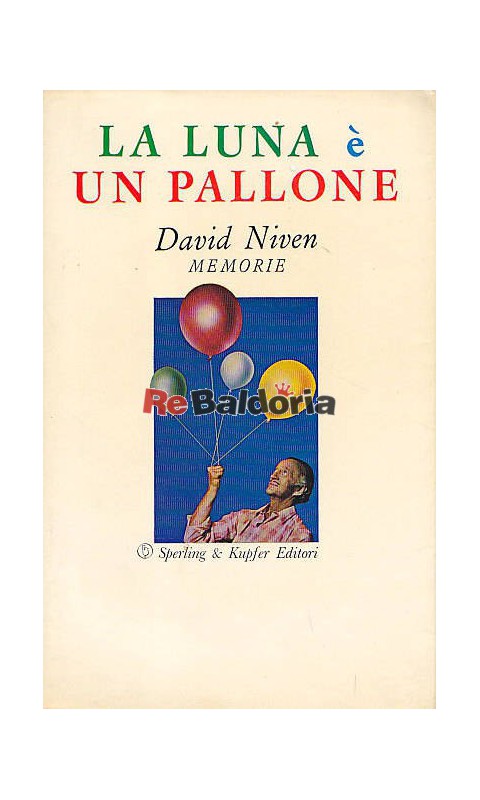Perché mai una persona decide di leggere l’autobiografia di David Niven?
Questo libro, vi parrà strano, non era esattamente ai primi posti nella mia lista di priorità letterarie. Capita che un giorno mi ritrovi a girare per mercatini dell’usato e venga attratta da questo cartello che dice 3 libri per 1 euro. Ora, nella mia religione, se si vede scritto 3 libri per 1euro, è considerato peccato mortale non soffermarsi a dare almeno un’occhiata, per quanto si debba essere m…oralmente preparati a trovare titoli quali “Come trattare gli altri e farseli amici” (un classico da bancarella), “Cento e una ricetta per bollire un uovo”, “Infuocata passione ai sole dei tropici”. Roba così, insomma.
Il vecchietto dietro la bancarella era simpatico e abbiamo iniziato a chiacchierare un po’. I libri, al contrario di quanto si possa pensare, erano in ottime condizioni. E, miracolo dei miracoli, nessuno di essi era “Come bollire un uovo”. Anzi, erano piuttosto interessanti. Sui primi due sono andata a colpo sicuro: addirittura due titoli di Diego Cugia, autore per lo più radiofonico che ho apprezzato molto in passato. Tra l’altro il vecchietto condivideva con me lo stesso interesse, per cui la chiacchierata si è prolungata sui pregi e difetti di Cugia. Restava da scovare il terzo titolo per completare l’euro. Prenda questo, mi dice il vecchietto, è divertente. Vuoi non dargli ascolto? Così, non solo mi sono portata a casa l’autobiografia di David Niven, ma mi sono anche sentita in dovere di leggerla. Vabbè, dai, per 33 centesimi poteva anche andarmi peggio, in fondo ho adorato i film di Niven.
Devo commentare il libro? Non entrerà tra i dieci migliori libri letti quest’anno, ma un 6 ½ mi sento di darglielo. Va da sé, è scritto con lo stile elegantemente ironico dell’attore inglese, per quanto certe freddure si perdano nella traduzione, temo. Molto schietto nel raccontare episodi personali di una vita che, scusate la banalità, è stata un romanzo. Alcuni dettagli avrei preferito continuare ad ignorarli: le stelle splendenti dei lontani fasti di Hollywood dovrebbero rimanere avvolte dal fascino di vecchie e patinate foto in bianco e nero. Per cui ho sorvolato su alcune parti e mi sono goduta le pagine popolate da amici che si chiamavano Gable, Bogart, Hepburn, Bacall, Dietrich.
Adesso però, lasciamolo tutta la combriccola a bere champagne nei loro eleganti abiti da sera insieme al fascinoso amico Niven. E’ questo che devono fare le glorie della vecchia Hollywood.
A breve penso che rivedrò Il giro del mondo in 80 giorni. Così, per ristabilire l’ordine naturale delle cose.
Anna LittleMax Massimino