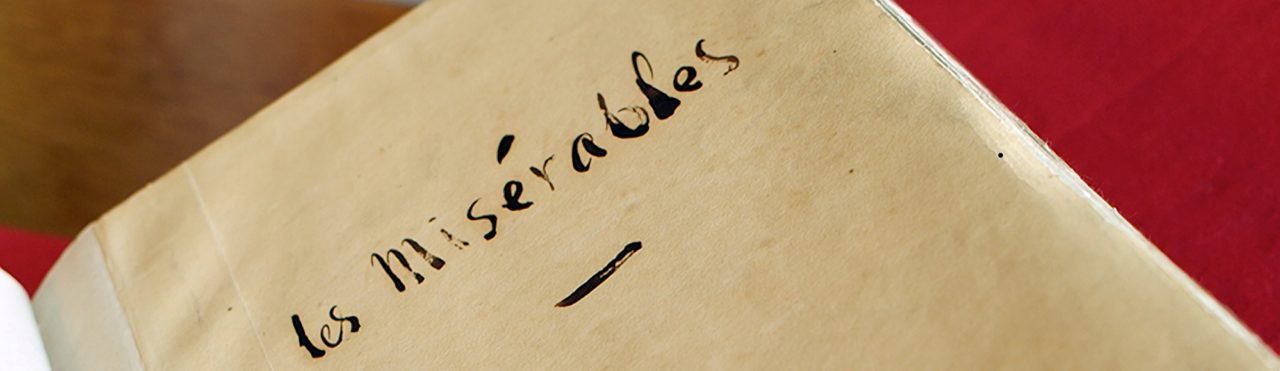Autore: Fernando Aramburu
Titolo: Patria
Traduzione: Bruno Arpaia
Editore: Guanda
Anno: 2017
Bittori, Miren, Il Txato, Joxian, Nerea, Xabier, Arantxa, Joxe Mari, Gorka: ho trascorso con loro quattro giorni e mi mancano tantissimo.
Sono i protagonisti di “Patria”, uno dei romanzi dell’anno anche grazie al meritato Premio Strega europeo. Un libro intenso che, attraverso le storie dei componenti di due famiglie, ci spinge a riflettere su importanti interrogativi: fin dove è etico, più che lecito, spingersi per perseguire un ideale politico? Chi sono le vittime di un conflitto sociale, di una guerra civile?
Sono domande che sarà inevitabile porsi, proseguendo nella lettura e riflettendo insieme ai personaggi, le cui storie catturano tutte senza esclusione.
Aramburu scrive in maniera molto particolare, con un uso personale del linguaggio che rompe alcuni schemi tradizionali dello scrivere, ma, dopo poche pagine, una volta abituatisi, il romanzo scorre fin troppo velocemente. Vorrei, infatti, non averlo finito o che ne esistessero non so quanti seguiti, per sapere com’è proseguita la vita dei protagonisti o addirittura cosa fanno, tutti, in questo preciso momento.
Euskal Herria è una parola intraducibile
In lingua basca vuol dire insieme il luogo e il popolo basco, il legame che non si può scindere tra la terra e il popolo che vi abita. Patria, dunque, è al tempo stesso aita e ama, ovvero papà e mamma, è appartenenza assoluta, come la famiglia, ma è anche tragedia, maledizione. Sembrava un residuo del passato, invece la patria è la protagonista della nostra epoca, fatta di Stati senza territorio, di territori senza Stato. Alla patria basca Fernando Aramburu ha dedicato il suo romanzo, un caso letterario in Spagna nel 2016, pubblicato in Italia da Guanda e tradotto da Bruno Arpaia, è ambientato negli anni del terrorismo separatista basco dell’Eta che ha provocato 829 morti tra il 1968 e il 2011. Oggi è la Catalogna a rivendicare la sua identità e indipendenza nel cuore dell’Europa che reclama l’appartenenza a una cultura comune, ma spesso rischia di parlare a uomini e donne che non condividono né radici, né futuro. Per questo occorre riflettere sul passato di una remota zona dell’Europa.” M.L. Bianchi
Dal punto di vista mio personale, poi, leggere “Patria” è stato tornare nell’amata San Sebastiàn: ritrovare i vicoli della Città Vecchia, la baia della Concha, la isla di Santa Chiara… Ricordi per me davvero importanti.
Ho ripensato molto ai miei giorni a Donostia, giorni vissuti in un periodo in cui l’ETA era viva e presente, in uno dei momenti di più intensa attività, e ai discorsi fatti con amici “euskaldun”, al mio sentirmi in qualche modo vicina alle idee “rosse” degli indipendentisti, pur se contraria alla lotta armata.
Questo romanzo mi ha fatto ripensare e rivalutare molte delle mie idee in merito, perché pone l’accento su aspetti che non avevo considerato prima e su cui non avevo mai riflettuto. Mi ha fatto ritornare in luoghi amati e ricordare giorni felici. Mi ha fatto amare questi baschi “di carta” e le loro storie come ho amato quelli reali.
– se esiste ancora, l’anno venturo vorrei tornare a L’Uraitz! –
Loretta Briscione
DESCRIZIONE
Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle domeniche in bicicletta. E anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia, così come i loro figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per sempre in un prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto vittima di un attentato… Bittori se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno ammazzato il marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno fastidio. Anche a quelli che un tempo si proclamavano amici. Anche a quei vicini di casa che sono forse i genitori, il fratello, la sorella di un assassino. Passano gli anni, ma Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso una riconciliazione necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte.
Con la forza della letteratura, Fernando Aramburu ha saputo raccontare una comunità lacerata dal fanatismo, e allo stesso tempo scrivere una storia di gente comune, di affetti, di amicizie, di sentimenti feriti: un romanzo da accostare ai grandi modelli narrativi che hanno fatto dell’universo famiglia il fulcro morale, il centro vitale della loro trama.