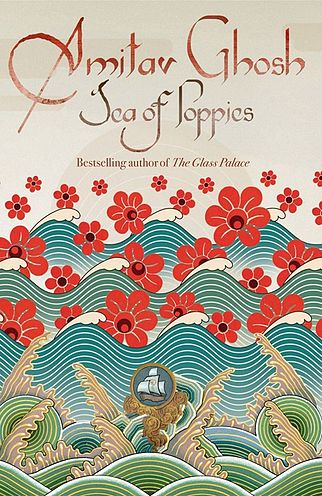«Accadde alla fine dell’inverno, in un anno in cui i papaveri furono stranamente lenti nello spargere i petali: per chilometri e chilometri, da Benares in su, sembrava che il Gange scorresse tra ghiacciai paralleli, entrambe le sponde infatti erano coperte da una folta distesa di petali bianchi».
Mare di papaveri è un tomone di 600 pagine, che fa parte di una trilogia di altri bei tomoni, dello scrittore indiano Amitav Ghosh. La storia è ambientata nell’India coloniale del primo ventennio del 1800, centrata sulle vicende che precedono la Prima Guerra dell’Oppio, dura operazione militare grazie alla quale i britannici ottennero l’apertura dei porti di Shangai e Canton e strapparono Hong Kong alla Cina, imponendo al Celeste Impero l’acquisto dell’oppio che le autorità locali avevano cercato di bandire per il dilagare della tossicodipendenza nel Paese.
E’ un romanzone corale, con un cast dickensiano che comprende una vedova fuggitiva dalla pira del defunto marito, uno schiavo liberato dagli Stati Uniti, un Rajah decaduto, un derviscio convinto di essere la reincarnazione di una santa, una ragazza francese cresciuta come un indù, e una miriade di altri personaggi minori, sia inglesi che indiani: sepoy, ufficiali, lascari, servitori, magistrati, clandestini, braccianti, galeotti, contabili. Questa infinita varietà di caratteri permette allo scrittore di narrare differenti situazioni e introdurre una serie di sottotrame e ambientazioni. Per esempio c’è l’esposizione dettagliata di uno stabilimento di raccolta e smistamento dell’oppio, terribile in tutti i particolari, comprese le descrizioni di uccelli e scimmie dei dintorni che vagano storditi dall’acqua e dall’aria contaminate dalle scorie della droga, e dei poveracci che girano in tondo calpestando i semi dell’oppio per diluirlo, spettri con gli occhi persi in un vuoto istupidito. Poi entriamo nel palazzo galleggiante di un Rajah di altissima casta, quindi nell’ufficio di uno dei più importanti mercanti inglesi di Calcutta, poi su una goletta (la Ibis) che sarà protagonista in tutti e tre i romanzi, infine visitiamo l’orrore di una prigione indiana.
Amitav Ghosh ha dichiarato di aver voluto scrivere questa trilogia per due motivi. Innanzitutto perchè pensa che la guerra dell’oppio sia uno dei momenti cruciali della modernità, il momento in cui l’Occidente impose con la forza il “libero” scambio e il “libero” commercio all’Oriente, affermando il modello capitalista, consumistico e voluttuario che caratterizza le economie moderne. La modernità in cui viviamo, con tutto il suo carico di problemi globali, le guerre mondiali, la globalizzazione, la penuria di risorse energetiche, i prodotti di consumo di massa, e persino il surriscaldamento del pianeta dipendono tutto sommato dalla spinta propulsiva e aggressiva del capitalismo ottocentesco. E gli inglesi, che avevano un problema economico non indifferente nel momento in cui si trovavano ad importare dalla Cina più di quanto esportassero, a causa della fortissima domanda interna di tè, seta e porcellana, trovarono il modo di equilibrare l’uscita con una nuova entrata: quella derivata dalla vendita dell’oppio indiano ai cinesi. Si inventarono un prodotto, assolutamente non necessario ma che creava dipendenza (letteralmente), cominciarono a produrlo in quantità industriale, e lo vendettero alle masse.
L’aspetto storico è quindi molto curato, ed è il focus primario di tutta la narrazione: quindi se vi piacciono il periodo della colonizzazione britannica in India, gli equilibri sociali di quel mondo, e gli effetti che il commercio dell’oppio ebbe su diverse realtà sociali, dai contadini che persero intere regioni di terreno coltivabile perchè la Compagnia delle Indie impose di seminare ovunque i papaveri da oppio, ai commercianti britannici che vi si arricchirono immensamente, ai militari e capi mercanti della Compagnia che decisero di scendere in guerra e così via, è un libro che vi piacerà.
L’altro motivo è quello del linguaggio. L’autore, indiano naturalizzato inglese e poi americano, ha speso anni a fare ricerche sul tipo di lingua che si parlava in India in quel periodo, che non era -ovviamente- un linguaggio unico. L’inglese che gli stessi britannici parlavano non era puro, ma bensì imbastardito da una serie di termini locali, hindi, urdu, mischiati a parole di altre lingue e dialetti indiani, cinesi, malesi, persino africani e arabi. Una burra-memsahib che doveva spiegare al cuoco bengalese quali pietanze volesse al banchetto, gli parlava -forse persino inconsapevolmente – in un inglese inframmezzato a una serie di vocaboli di varie altre lingue, che cambiava nel momento si rivolgeva al suo giardiniere o alla sua sarta, e che ovviamente diventava meno imbastardito se parlava a un suo pari britannico. Al tempo stesso tutti i contadini, i coolies, i marinai, i soldati, i commercianti e gli impiegati negli uffici parlavano tra loro il proprio dialetto, e per farsi capire dagli inglesi e da altri stranieri che transitavano sul loro cammino ricorrevano a un inglese permeato da una serie infinita di termini di varia origine, che usavano come una specie di esperanto universale.
Questo sforzo di realismo nella trascrizione dei dialoghi (a dire il vero ammirevole) dell’autore, lo ha portato a livelli che si potrebbero definire maniacali, ricostruendo frase su frase per personaggio la lingua che si pensa questi parlasse in quell’epoca, a seconda del proprio dialetto e della propria estrazione sociale. Dopodichè, ha proibito ai traduttori dei vari paesi di mettere un glossario e note esplicative. Per cui ci si scontra con una miriade di termini di quell’esperanto cui accennavo sopra, che impestano paragrafi interi, a tal punto che ci sono complete frasi del tutto incomprensibili. Per chi è appassionato di lingue, è interessante procedere ammirando via via il lavoro certosino dei traduttori. Però su un libro di 600 pagine, diventa una sfida continua che rallenta la lettura, e il più delle volte si passa oltre saltando a piè pari una frase sperando che prima o poi il senso torni. Esempio a caso: “Ogni volta veniva duramente rimbrottato da serang e tindal, coksen e nostromi; un irritabile bhandari gli rovesciò addosso un secchio di acqua sporca”.
In conclusione, questo è un romanzo che nelle intenzioni dell’autore si colloca a metà tra il romanzo storico avventuroso alla Kipling, e il feuilletton à la Dumas. In realtà, è un libro dalla narrazione lenta, a tratti pure noiosa, che ti lascia a volte sospirare pensando a cosa avrebbe tirato fuori Salgari da una trama con al centro una goletta che porta un equipaggio di lascari, leggendari marinai del Pacifico appartenenti alle razze più disparate, cinesi, africani, arabi, malesi, bengalesi e tamil, e i vari passeggeri i cui destini tutti si incroceranno sull’Oceano Indiano.
In ogni caso, assolutamente non è un brutto libro, mi è piaciuto, e leggerò di sicuro gli altri due della trilogia (anche perchè sono tutti strettamente collegati, e questo finisce all’improvviso rimandandoti a tutti gli effetti alle puntate successive), perchè gli argomenti di cui parla mi hanno da sempre affascinato. Ma questi difetti che ho sottolineato possono davvero frenare il piacere della lettura, quindi tenetene conto.
“Caro signore, la verità è che gli uomini fanno quello che il potere che amministrano gli permette di fare. Noi non siamo diversi dai Faraoni o dai Mongoli: la differenza sta solamente nel fatto che quando uccidiamo ci sentiamo obbligati a dire che è per una causa superiore. Ma questo pretesto di virtuosità, ve lo assicuro, non ci verrà mai perdonato dalla storia”.
Lorenza Inquisition