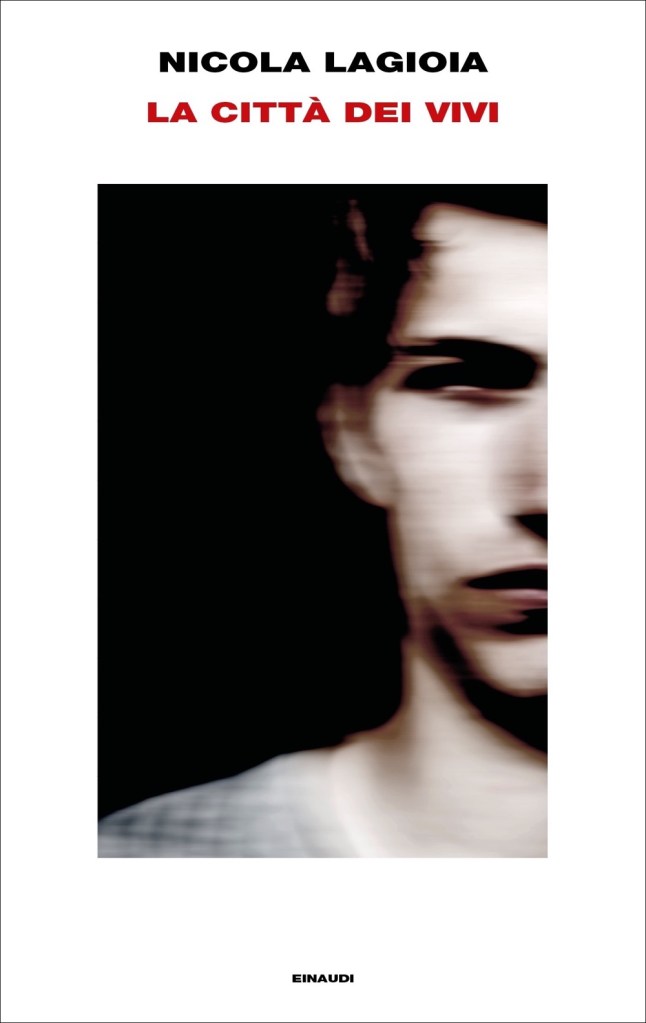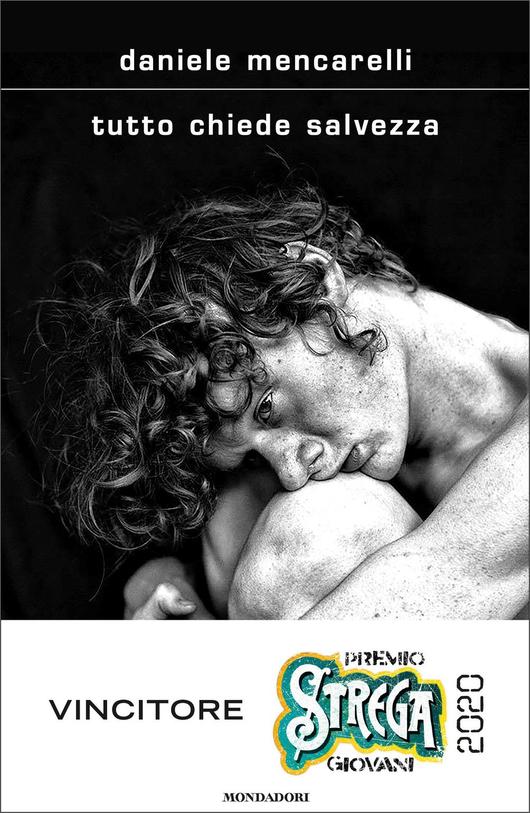“C’è un’aridità a cui è meglio non avvicinarsi. Si trova in noi ed è meglio ignorare l’estensione che occupa nella nostra anima” Alvaro Mutis, La neve dell’ammiraglio
Io non seguo la cronaca nera: odio il modo in cui viene raccontata, odio gli sciacalli, le domande assurdamente retoriche ai parenti delle vittime, il “come si sente?” dei giornalisti avvoltoi che brandiscono microfoni come fossero una giustificazione o un’arma, i “salutava sempre”, le trasmissioni televisive di finto approfondimento che servono solo ad assolverci tutti restituendo sempre l’immagine dei colpevoli come dei mostri pazzi avulsi dalla società e rassicurandoci così che non potrebbe mai toccare a noi, che siamo normali, ma allo stesso tempo solleticando la peggiore morbosità insita in ognuno di noi. Soprattutto odio il tribunale mediatico, del tutto privo di riscontri, di umanità, di analisi che serve solo per il rituale del quarto d’ora d’odio di orwelliana memoria.
Diversa è l’analisi di un evento di cronaca nera finalizzata alla comprensione di ciò che quell’evento porta con sè: in questo senso, maestro, almeno in Italia, è stato Giorgio Scerbanenco, che partiva dalla sua esperienza di giornalista per comporre ritratti di personaggi e ambienti magistrali. Lagioia, nel solco di quella stessa tradizione ma con un approccio più documentaristico che romanzato, scava in uno dei delitti degli ultimi anni, quello di Luca Varani, ucciso in un palazzo alla periferia di Roma da Manuel Foffo e Marco Prato, senza voler assolvere o condannare nessuno ma cercando di capire cosa abbia potuto portare due ragazzi ad ammazzarne un altro senza alcun movente né di tipo economico, né di vendetta: addirittura Manuel Foffo non aveva mai incontrato la vittima prima della notte dell’omicidio. Lo scenario è quello di una Roma devastata dall’incuria, dal cinismo, dalla corruzione, invasa dalla spazzatura e dai topi, martoriata dalle inchieste giudiziarie (il Mondo di Mezzo di Carminati, che, in un’intercettazione, divide il mondo tra quello dei vivi e quello dei morti, da cui il titolo del libro) in cui il delitto insensato sembra quasi, nella narrazione di Lagioia, l’apice del degrado a cui segue un diluvio torrenziale che in un romanzo sarebbe catartico, mentre nella realtà è solo un episodio atmosferico.
Riflettendo sull’odio che come sempre questi episodi di cronaca nera scatenano, e sulla sete di vendetta vomitata da ogni parte, Lagioia scrive:”Ma vendetta per cosa? Ci sentivamo umiliati, avevamo bisogno di umiliare. Ci sentivamo feriti, avevamo bisogno di ferire. Ci sentivamo in fondo mediocri, stupidi, pavidi e inessenziali, nel crepuscolo di un’epoca che aveva promesso di farci ricchi, intelligenti, coraggiosi. Ci davamo di conseguenza molto da fare per non guardare in faccia la realtà, agitavamo il nostro fallimento spacciandolo per la prova della nostra onestà, della nostra bontà, della nostra lucidità, quando non della nostra purezza, e partivamo a caccia di colpevoli (o iniziavamo a fabbricarceli) pur di tenere in piedi il castello di carte”.
Il romanzo è molto pasoliniano, anche perché si muove nel solco di quell’analisi che vede la cultura popolare sostituita da quella dei consumi, i cittadini sostituiti dagli utenti, il tessuto sociale spossessato di ogni senso di comunità lasciando un vuoto colmato dalla droga che scorre a fiumi. Al di là del movente del delitto, la riflessione di Lagioia vuole addentrarsi in fondo al pozzo, ammettendo di averlo lui stesso scrutato, almeno superficialmente, quando da ragazzo si gettò in imprese scriteriate, molto lontane della gravità di un delitto sia chiaro, ma che avrebbero potuto rovinarlo per sempre se fossero andate diversamente. “Sono stato fortunato” dice di se stesso, ricordando quegli episodi. “Non riesco a dire se fu più un eccesso di imbecillità o di fragilità a farmi finire nei guai. Sono certo tuttavia che, una volta nei pasticci, se non avessi reagito da scriteriato avrei avuto la peggio. […] le mie risorse di allora, voglio dire, erano così scarse che non mi avrebbero consentito di uscire senza sregolatezze – e sregolatezze piuttosto pericolose – dal vicolo cieco in cui mi ero ficcato. Ci era voluto più di uno strappo violento per tirarsene fuori”. Parte della responsabilità di queste azioni viene attribuita dall’autore ad una situazione famigliare complicata ma Lagioia non è accondiscendente con se stesso e confessa:”Il dolore, a volte, è solo il pretesto per dare sfogo alla propria personale imbecillità, o al narcisismo più sfrenato”.
Allora possiamo rimanere tranquilli davanti alla tivù a urlare alla pena di morte per i mostri, oppure cercare di trovare, per quanto sia difficile, un punto di contatto con gli assassini, non per assolverli, non per sminuire il dolore della vittima e dei suoi cari, non per giudicare, ma per capire. Riconoscere la fragilità e la debolezza di ognuno di noi, nella sua particolare e unica specificità motivata dai conflitti famigliari, dalla difficoltà di costruire una proprio identità nel mondo della competizione sfrenata, dai giudizi che tropppo spesso dispensiamo costruendo modelli irraggiungibili per noi stessi e per gli altri; tutti omologati, tutti perfettamente inseriti in una società alienata, tutti frustrati. Marco Prato si uccise in carcere mentre Manuel Foffo venne condannato a 30 anni di reclusione. Lagioia, in chiusura, riporta un’ultima riflessione derivante da un libro che gli viene consigliato, “Il libro dell’incontro” in cui si documenta il percorso che porta alcune delle vittime della violenza degli anni di piombo ad incontrare, con dei mediatori, gli autori degli omicidi dei loro cari, partendo da due presupposti fondamentali per dare un senso all’operazione: “da una parte i responsabili della lotta armata erano consapevoli di aver distrutto la vita di intere famiglie, dall’altra i parenti delle vittime erano pronti a riconoscere la piena umanità delle controparti”. La piena umanità. La stessa che pretendo sia riconosciuta a me, la stessa che vogliamo venga riconosciuta a ciascuno di noi. Il padre della vittima, in chiusura del libro, lamenta di non aver mai ricevuto una telefonata dai genitori degli assassini. Il tema della riconciliazione, del senso della carcerazione come compensazione dell’errore, della reintegrazione in società dei rei viene qui accennato ma è un tema su cui la letteratura, a partire da “Resurrezione” di Tolstoj, si è spesso interrogata. In ogni caso, la pena non può essere quella di privare dell’umanità i colpevoli, come troppo spesso accade nelle carceri o addirittura ancora prima quando non si sono celebrati i processi e non sono state chiarite le responsabilità. Dovremmo comunque almeno provare ad esercitare quell’umanità che vogliamo ci venga riconosciuta, soprattutto quando sembra che non ci ci sia spazio per quell’esercizio. Mi chiedo: io sarei in grado di farlo nei confronti di qualcuno che facesse del male ai miei cari? Molto onestamente, non lo so. Essere umani vuol dire prima di tutto ammettere le proprie debolezze e poi provare a farci i conti senza nasconderle e senza nemmeno farle diventare un alibi. O almeno credo.
Edoardo Alessandro Maria
«Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell’incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?»
La città dei vivi – Nicola Lagioia
Einaudi, 2020
Supercoralli pp. 472
ISBN 9788806233334