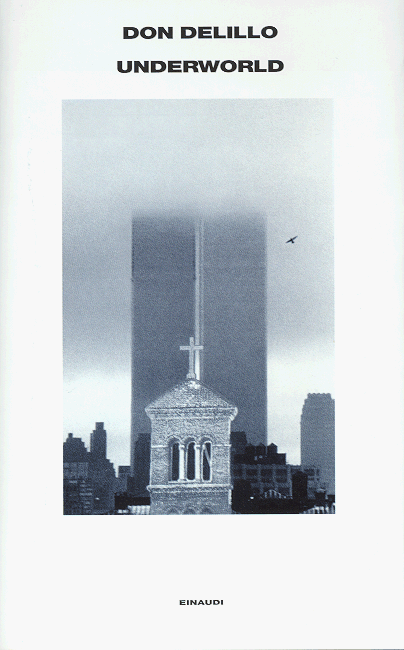Parla la tua lingua, l’americano, e c’è una luce nel suo sguardo che è una mezza speranza. È un giorno di scuola, naturalmente, ma lui non c’è proprio, in classe. Preferisce star qui, invece, all’ombra di questa specie di vecchia carcassa arrugginita, e non si può dargli torto – questa metropoli di acciaio, cemento e vernice scrostata, di erba tosata ed enormi pacchetti di Chesterfield di sghimbescio sui tabelloni segnapunti, con un paio di sigarette che sbucano da ciascuno. Sono i desideri su vasta scala a fare la storia. Lui è solo un ragazzo con una passione precisa, ma fa parte di una folla che si sta radunando, anonime migliaia scese da autobus e treni, gente che in strette colonne attraversa marciando il ponte girevole sul fiume, e sebbene non siano una migrazione o una rivoluzione, un vasto scossone dell’anima, si portano dietro il calore pulsante della grande città e i loro piccoli sogni e delusioni, quell’invisibile nonsoché che incombe sul giorno – uomini in cappello di feltro e marinai in franchigia, il ruzzolio distratto dei loro pensieri, mentre vanno alla partita.
[Don DeLillo, Underworld, traduzione di Delfina Vezzoli, Einaudi, Torino, 1999]
Le Twin Towers in costruzione, la guerra fredda e la sua fine, l’omicidio di JFK, Edgar J. Hoover, gli esperimenti nucleari americani e sovietici, la crisi dei missili a cuba letta attraverso i racconti degli spettacoli di Lenny Bruce, i rifuiti accumulati dalla società dei consumi per eccellenza, e l’apparente redenzione della stessa società, pacificata e rasserenata nelle attività di riciclaggio. Il tutto riflesso nelle mille schegge in cui viene frantumato mezzo secolo di …storia americana, rimesse assieme in modo apparentemente casuale. Storie che si intrecciano e si accavallano, avanti e indietro negli ultimi 50 anni del secolo scorso, seguendo i passaggi di mano di una pallina da baseball.
Due considerazioni mie:
1. Leggere questo libro è un po’ come guardare le immagini dipinte sulla vetrata di una cattedrale medievale, ma guardarli a terra, in frantumi, dopo un terremoto. Ogni frammento coloratissimo, brillante e lucente di una bellezza ipnotica che non ti permette di staccare gli occhi da quella confusione acuminata, alla ricerca di due bordi che possano coincidere.
2. Leggere questo libro e pensare che è stato scritto quattro o cinque anni prima dell’Undici Settembre fa un po’ impressione. Non perché venga fatto alcun accenno a quello che sarebbe diventato il mondo dopo, anzi (il libro finisce con la parola “Pace”, pensate un po’) ma perché, a leggerlo con gli occhi che abbiamo adesso, viene da pensare che, se quelle era il nostro passato, probabilmente quello che c’è adesso era poi l’unico futuro possible.
Luca Bacchetti